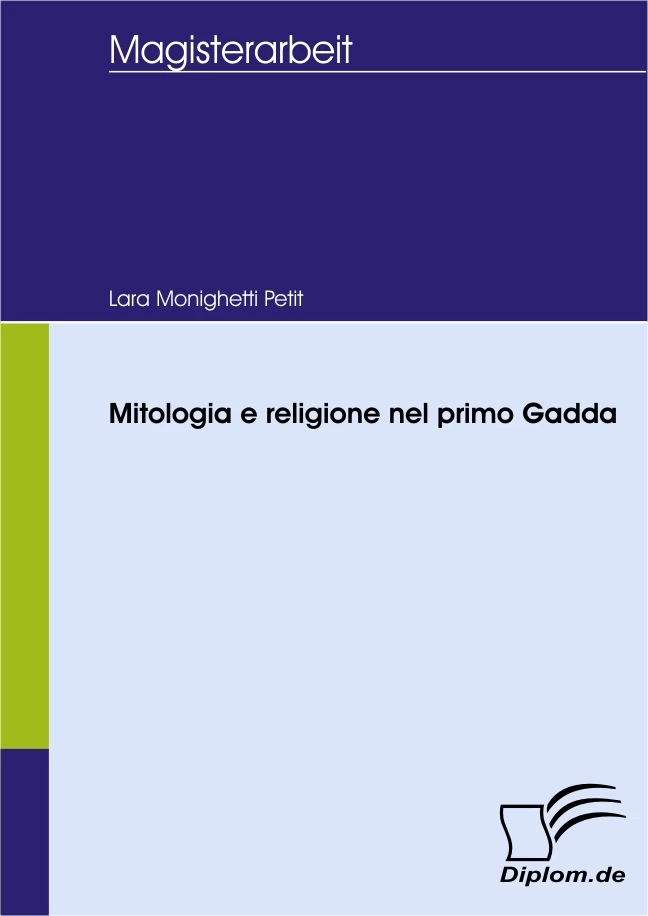Mitologia e religione nel primo Gadda
©2004
Magisterarbeit
106 Seiten
Zusammenfassung
Inhaltsangabe:Introduzione:
Nella sterminata bibliografia su Gadda (Milano 1893 - Roma 1973) mancano studi sistematici sulla stilistica delle fonti. Sono stati messi in luce i suoi legami con Manzoni e con la tradizione lombarda, ma non sono ancora stati analizzati i suoi rapporti con la tradizione classica e cristiana.
Gadda è conosciuto dal grande pubblico sopratutto per il suo celebre romanzo Quer Pasticciaccio brutto de via Merulana; molto meno noti sono invece i suoi diari di guerra o i primi romanzi. Anche la critica si è occupata prevalentemente del Pasticciaccio, dimenticando spesso di inserire nelle ricerche tematiche le prime opere.
Questo lavoro si propone di studiare quale tipo di cultura classica e cristiana possieda Gadda e come proceda nei confronti della tradizione. Lo studio si concentra sui primi romanzi (La Madonna dei Filosofi, Il Castello di Udine, Un Fulmine sul 220 e LAdalgisa) e analizza come Gadda utilizzi elementi mitologici e religiosi, in quale momento li inserisca, con quale funzione, e per ottenere quale effetto.
Su questo argomento esiste unicamente lo studio di Rinaldi, che analizza un elemento mitologico in particolare. Essendo il campo ancora praticamente inesplorato si intende accertare in modo generale se vi sia un modo specifico con cui Gadda si confronta con la mitologia e la religione, o se gli elementi abbiano funzioni diverse. Come detto il presente studio si iscrive nella tradizione della stilistica delle fonti, ma proprio la matrice fonti risulta problematica nel caso di Gadda.
Lipotesi è che la Bibbia e la liturgia, come i miti, non siano fonte dispirazione a cui Gadda si rifà per narrare un episodio religioso o mitico, ma che gli elementi religiosi e mitologici siano un modo per parlare daltro. Anche la linea della parodia è rilevante per questa analisi.
Mancando uno studio analogo ci si trova talvolta privi di supporti critici con cui fare dei paragoni, che possano supportare o smentire le tesi e le affermazioni, ma la difficoltà maggiore consiste nella scelta della metodologia danalisi. Lo studio di Rinaldi, benché tematicamente affine, non offre un approccio applicabile a unindagine sistematica degli elementi mitologici (e religiosi). È stato scelto come modello danalisi Il libro di Jacopo. Scrittura sacra nellOrtis di Terzoli che si rivela un illustre esempio per questo tipo di indagine.
Risolto il problema della metodologia rimane da delimitare lambito della ricerca. Per la prima […]
Nella sterminata bibliografia su Gadda (Milano 1893 - Roma 1973) mancano studi sistematici sulla stilistica delle fonti. Sono stati messi in luce i suoi legami con Manzoni e con la tradizione lombarda, ma non sono ancora stati analizzati i suoi rapporti con la tradizione classica e cristiana.
Gadda è conosciuto dal grande pubblico sopratutto per il suo celebre romanzo Quer Pasticciaccio brutto de via Merulana; molto meno noti sono invece i suoi diari di guerra o i primi romanzi. Anche la critica si è occupata prevalentemente del Pasticciaccio, dimenticando spesso di inserire nelle ricerche tematiche le prime opere.
Questo lavoro si propone di studiare quale tipo di cultura classica e cristiana possieda Gadda e come proceda nei confronti della tradizione. Lo studio si concentra sui primi romanzi (La Madonna dei Filosofi, Il Castello di Udine, Un Fulmine sul 220 e LAdalgisa) e analizza come Gadda utilizzi elementi mitologici e religiosi, in quale momento li inserisca, con quale funzione, e per ottenere quale effetto.
Su questo argomento esiste unicamente lo studio di Rinaldi, che analizza un elemento mitologico in particolare. Essendo il campo ancora praticamente inesplorato si intende accertare in modo generale se vi sia un modo specifico con cui Gadda si confronta con la mitologia e la religione, o se gli elementi abbiano funzioni diverse. Come detto il presente studio si iscrive nella tradizione della stilistica delle fonti, ma proprio la matrice fonti risulta problematica nel caso di Gadda.
Lipotesi è che la Bibbia e la liturgia, come i miti, non siano fonte dispirazione a cui Gadda si rifà per narrare un episodio religioso o mitico, ma che gli elementi religiosi e mitologici siano un modo per parlare daltro. Anche la linea della parodia è rilevante per questa analisi.
Mancando uno studio analogo ci si trova talvolta privi di supporti critici con cui fare dei paragoni, che possano supportare o smentire le tesi e le affermazioni, ma la difficoltà maggiore consiste nella scelta della metodologia danalisi. Lo studio di Rinaldi, benché tematicamente affine, non offre un approccio applicabile a unindagine sistematica degli elementi mitologici (e religiosi). È stato scelto come modello danalisi Il libro di Jacopo. Scrittura sacra nellOrtis di Terzoli che si rivela un illustre esempio per questo tipo di indagine.
Risolto il problema della metodologia rimane da delimitare lambito della ricerca. Per la prima […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Lara Monighetti Petit
Mitologia e religione nel primo Gadda
ISBN: 978-3-8366-2969-0
Herstellung: Diplomica® Verlag GmbH, Hamburg, 2009
Zugl. Universität Basel, Basel, Schweiz, Magisterarbeit, 2004
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte,
insbesondere die der Übersetzung, des Nachdrucks, des Vortrags, der Entnahme von
Abbildungen und Tabellen, der Funksendung, der Mikroverfilmung oder der
Vervielfältigung auf anderen Wegen und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen,
bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. Eine Vervielfältigung
dieses Werkes oder von Teilen dieses Werkes ist auch im Einzelfall nur in den Grenzen
der gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes der Bundesrepublik
Deutschland in der jeweils geltenden Fassung zulässig. Sie ist grundsätzlich
vergütungspflichtig. Zuwiderhandlungen unterliegen den Strafbestimmungen des
Urheberrechtes.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in
diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme,
dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei
zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.
Die Informationen in diesem Werk wurden mit Sorgfalt erarbeitet. Dennoch können
Fehler nicht vollständig ausgeschlossen werden und der Verlag, die Autoren oder
Übersetzer übernehmen keine juristische Verantwortung oder irgendeine Haftung für evtl.
verbliebene fehlerhafte Angaben und deren Folgen.
© Diplomica Verlag GmbH
http://www.diplomica.de, Hamburg 2009
1
L
ARA
M
ONIGHETTI
M
ITOLOGIA E RELIGIONE
NEL PRIMO
G
ADDA
Referente:
Coreferente:
Prof. Dr. M.A. Terzoli
Prof. Dr. G. Regn
Ordinarius für Italienische Literatur
Ordinarius für Italienische Philologie
Universität
Basel
Ludwig
Maximilians
Universität
Romanisches
Seminar Institut für Italienische Philologie
Stapfelberg
7-9 Ludwigstrasse
25
CH-4051
Basel D-80539
München
2
I
NDICE
1.
Introduzione
p.
4
Parte I
p. 7
2.
Materia
e
motivazioni
p.
8
3.
Presentazione
degli
elementi
mitologici
p.
11
3.1 Schede
per
gli
Indici
p. 11
3.2
Funzione stilistica degli elementi mitologici
p. 14
3.2.1 Ekphrasis
p. 15
3.2.2
Metafora
p.
16
3.2.3
Paragone
p.
18
3.2.4
Elenco
p.
19
3.2.5
Epigrafe
e
citazione
p.
20
3.3
Gadda e la tradizione classica
p. 21
4.
Presentazione
degli
elementi
religiosi p.
23
4.1 Schede
per
gli
Indici
p. 23
4.2
Funzione stilistica degli elementi religiosi
p. 23
4.2.1 Ekphrasis
p. 24
4.2.2
Metafora
p.
25
4.2.3
Paragone
p.
27
4.2.4
Elenco
p.
28
4.2.5
Citazione
p.
29
4.3
Forme narrative di matrice cristiana
p. 34
4.3.1
Preghiera
p.
35
4.3.2
Racconto
apocalittico
p.
37
4.3.3
Laude
p.
40
4.3.4 Exemplum
p. 42
4.3.5
Racconto
agiografico
p.
47
4.4
Gadda e la tradizione cristiana
p. 50
Parte II
p. 53
5.
La società musogonica (o lo Stangermann purgatorio)
p. 54
6.
Il Credo nel Politecnico (o il paradiso cavigiolo)
p. 63
7.
La
figura
del
prete
p.
69
8.
I
soldati:
santi
e
martiri p.
80
8.1
Il francescanesimo: l'umile fante vs. il soldato d'Italia
p. 82
8.2
Il
sacrificio
p.
84
3
Parte III
p. 88
9.
Conclusione
p.
89
10.
Tavola
delle
sigle
p.
92
11.
Bibliografia
p.
93
Appendice
p. 97
12.1
Elementi
mitologici
p.
98
12.2 Elementi
religiosi
p.101
4
1.
I
NTRODUZIONE
Nella sterminata bibliografia su Gadda (Milano 1893 - Roma 1973) mancano
studi sistematici sulla stilistica delle fonti. Sono stati messi in luce i suoi legami con
Manzoni e con la tradizione lombarda, ma non sono ancora stati analizzati i suoi
rapporti con la tradizione classica e cristiana.
Gadda è conosciuto dal grande pubblico sopratutto per il suo celebre romanzo
Quer Pasticciaccio brutto de via Merulana; molto meno noti sono invece i suoi diari di
guerra o i primi romanzi. Anche la critica si è occupata prevalentemente del
Pasticciaccio, dimenticando spesso di inserire nelle ricerche tematiche le prime opere.
Questo lavoro si propone di studiare quale tipo di cultura classica e cristiana
possieda Gadda e come proceda nei confronti della tradizione. Lo studio si concentra sui
primi romanzi (La Madonna dei Filosofi, Il Castello di Udine, Un Fulmine sul 220 e
L'Adalgisa) e analizza come Gadda utilizzi elementi mitologici e religiosi, in quale
momento li inserisca, con quale funzione, e per ottenere quale effetto.
Su questo argomento esiste unicamente lo studio di Rinaldi,
1
che analizza un
elemento mitologico in particolare. Essendo il campo ancora praticamente inesplorato si
intende accertare in modo generale se vi sia un modo specifico con cui Gadda si
confronta con la mitologia e la religione, o se gli elementi abbiano funzioni diverse.
Come detto il presente studio si iscrive nella tradizione della stilistica delle fonti, ma
proprio la matrice "fonti" risulta problematica nel caso di Gadda.
L'ipotesi è che la Bibbia e la liturgia, come i miti, non siano fonte d'ispirazione
a cui Gadda si rifà per narrare un episodio religioso o mitico, ma che gli elementi
religiosi e mitologici siano un modo per parlare d'altro. Anche la linea della parodia è
rilevante per questa analisi.
Mancando uno studio analogo ci si trova talvolta privi di supporti critici con cui
fare dei paragoni, che possano supportare o smentire le tesi e le affermazioni, ma la
difficoltà maggiore consiste nella scelta della metodologia d'analisi. Lo studio di
Rinaldi, benché tematicamente affine, non offre un approccio applicabile a un'indagine
1
R.
R
INALDI
,
I dioscuri senza Leda: biografia e letteratura nel primo Gadda, in La coscienza infelice.
Carlo Emilio Gadda, a cura di A.
A
NDREINI E
M.
G
UGLIEMINETTI
, Milano, Guerini e Associati, 1996, pp.
41-95.
5
sistematica degli elementi mitologici (e religiosi). È stato scelto come modello d'analisi
Il libro di Jacopo. Scrittura sacra nell'Ortis di Terzoli
2
che si rivela un illustre esempio
per questo tipo di indagine.
Risolto il problema della metodologia rimane da delimitare l'ambito della
ricerca. Per la prima fase, nelle schede, non sono inclusi nelle tabelle esclamazioni,
imprecazioni, ingiurie e bestemmie, in quanto fanno parte del linguaggio gaddiano e
non apportano profondità a questo tipo di ricerca; questa tipologia di elementi è
frequente e ripetitiva, e sarebbe interessante per uno studio lessicale ma non per
l'indagine che qui si intende affrontare. Nei testi compaiono riferimenti all'anima
3
e a
nomi di santi (come toponimi o indicanti una data) che, data la frequenza con cui Gadda
li impiega, dovrebbero essere studiati separatamente, e non figurano dunque nel
materiale raccolto. Questa analisi non si occupa di studiare sistematicamente la cultura
di Gadda, diversamente occorrerebbe considerare le sue letture, gli autori che ama
citare, i personaggi storici a cui fa riferimento, le correnti di pensiero che menziona.
Anche l'aspetto autobiografico non è qui messo in luce. Per alcuni elementi esaminati,
in particolare per l'ekphrasis, è stato possibile dare solo una panoramica, senza poter
offrire un'analisi esaustiva.
Il metodo scelto è quello di un'analisi a due livelli: per la microstruttura si
analizza la funzione stilistica, per la macrostruttura la struttura narrativa. Un'analisi
quantitativa, svolta al momento della schedatura, non basta infatti a indagare il retroterra
di Gadda. Lavorare inoltre con l'ipotesi delle "fonti", matrice che è spesso utilizzata in
questo tipo di ricerca, non avrebbe permesso di approfondire l'analisi. Per dare lo stesso
peso e valore a questioni stilistico-strutturali come a quelle tematiche, si analizzano in
modo approfondito, nella seconda sezione, degli esempi significativi di come Gadda usi
gli elementi religiosi e mitologici.
Il lavoro sarà strutturato in tre grandi parti. La prima (capitoli 1-4) di carattere
generale, la seconda (capitoli 5-8) con alcuni elementi specifici presi dalla prima parte e
2
M.
A.
T
ERZOLI
, Il libro di Jacopo. Scrittura sacra nell'Ortis, Roma, Salerno, 1988.
3
Esiste uno studio su questo tema che purtroppo considera solo en passant le opere qui considerate e
sarebbe quindi opportuna un'analisi ulteriore. Da una prima immersione nel tema mi sembra che i testi
offrano molto materiale interessante per la tesi di Leucadi (cfr. G.
L
EUCADI
, Il naso e l'anima. Saggio su
Carlo Emilio Gadda, Bologna, Il Mulino, 2000).
6
analizzati in modo approfondito (non è infatti possibile per ogni elemento schedato
fornire qui un'analisi esaustiva) e infine la terza parte (capitolo 9) con le conclusioni.
La prima parte è introduttiva, ed è costituita da tre capitoli. L'obiettivo del primo
è di definire l'oggetto dell'analisi e di spiegarne la scelta e le motivazioni. Si presenta
dunque l'autore considerato, la parte della produzione letteraria esaminata e il motivo
per cui si lavora su religione e mitologia (capitolo 2). Il secondo e il terzo capitolo sono
strutturati in modo abbastanza simile: vi si presentano gli elementi mitologici (capitolo
3) e quelli religiosi (capitolo 4). Per entrambe categorie sono presentate le schede degli
elementi, condensate in una tabella (appendice 12.1 e 12.2) che può essere letta anche
come completamento degli Indici
4
(capitoli 3.1 e 4.1). Nel capitoletto successivo si
esaminano le funzioni stilistiche che gli elementi raccolti ricoprono (capitoli 3.2 e 4.2);
si considera dunque la microstruttura. Per la religione è stato possibile studiare anche le
forme narrative di matrice cristiana (capitolo 4.3), ovvero la macrostruttura. Questi tre
passaggi permettono di illustrare nei primi risultati come Gadda proceda nei confronti
della tradizione classica e cristiana (capitoli 3.3 e 4.4).
Dopo questa parte di ordine generale segue una parte esemplificativa, in cui sono
studiati alcuni elementi ricorrenti: la società musogonica (capitolo 5), il Credo nel
Politecnico (capitolo 6), la figura del prete (capitolo 7) e i soldati come santi e martiri
(capitolo 8). Quest'analisi, di tipo tematico, permette di esaminare in modo più mirato
alcuni elementi e di verificare se le conclusioni a cui aveva portato l'indagine "di
superficie" è confermata da questa "di profondità".
In conclusione, nella terza parte (capitolo 9), anche tramite il confronto tra
mitologia e religione, si tenta di chiarire quale sia il retroterra gaddiano, come utilizzi la
tradizione nei suoi testi e quale effetto voglia creare. Si indicheranno anche quali siano
le novità apportate dall'analisi e quali campi non siano stati esplorati, questi
determineranno le direzioni delle prossime ricerche.
4
C.
E.
G
ADDA
, Bibliografia e Indici, a cura di D.
I
SELLA
,
G.
L
UCCHINI E
L.
O
RLANDO
, Milano, Garzanti,
1993. Nel testo verrà indicato solo come Indici.
7
P
ARTE
I
8
2.
L
A MATERIA E MOTIVAZIONI
Nel titolo della presente ricerca compare l'indicazione che si lavora sul "primo
Gadda". Con questa definizione convenzionale si intende il Gadda narratore tra la prima
e la seconda guerra mondiale, non il debuttante che scrive i diari di guerra (dal fronte e
in prigionia), né lo scrittore affermato di Quer pasticciaccio brutto de via Merulana
(pubblicato a partire dal 1946). È il Gadda che scrive e pubblica nel periodo fascista che
verrà analizzato. L'etichetta "primo Gadda" è qui estesa al 1944, quando pubblica
L'Adalgisa.
Gadda
5
comincia a scrivere durante la prima guerra mondiale; rientrato a
Milano, interrompe la scrittura fino al 1924, quando comincia la stesura del Racconto
italiano del Novecento, che abbandona poi nel 1925, anno in cui viene instaurato il
regime fascista. La mia analisi si occupa degli anni 1925-1945: all'interno di questo
periodo sono prese in considerazione solo gli scritti comparsi in volume (escluse le
traduzioni e le raccolte di prose): La Madonna dei filosofi (1931; MdF);
6
Il Castello di
Udine (1934; CdU);
7
e L'Adalgisa. Disegni milanesi (1944; L'A).
8
Viene incluso anche
Un fulmine sul 220 (F220),
9
che, benché pubblicato postumo nel 2000 da Isella, fu
ideato nel 1931 e scritto, senza essere dato alle stampe, tra il 1932 e il 1936. La stesura,
certamente non definitiva, è dunque stata fatta negli anni che ci interessano, e uno
spunto del romanzo è apparso nel 1941. La materia di questo romanzo verrà poi ripresa
e rielaborata per L'Adalgisa. La decisione di includere F220 è da intendersi anche
5
Non si ricorda qui la vita di Gadda perché non sono state svolte delle indagini in questo senso e
l'elemento biografico risulta marginale in questa analisi. Rinvio dunque per la biografia alla seguente
bibliografia: G.
C.
F
ERRETTI
, Ritratto di Gadda, Roma-Bari, Laterza, 1987; A.
P
ECORARO
, Gadda, Roma-
Bari, Editori Laterza, 1998; G.
C.
R
OSCIONI
, Il duca di Sant'Aquila. Infanzia e giovinezza di Gadda,
Milano, Arnoldo Mondadori, 1997; A.
S
ERONI
, Carlo E. Gadda, Firenze, La Nuova Italia, («I castori»),
1969 (2. ed.1971).
6
Nel testo l'opera C.E.
G
ADDA
, La Madonna dei filosofi sarà indicata con la sigla MdF e si riferisce
all'edizione compresa in C.
E.
G
ADDA
, Romanzi e Racconti I, a cura di R.
R
ODONDI
,
G.
L
UCCHINI
,
E.
M
ANZOTTI
, edizione diretta da D.
I
SELLA
, Milano, Garzanti, 1988 (= RRI), pp. 3-107.
Sono state riprese le stesse sigle che compaiono in RRI.
7
Nel testo sarà indicato con CdU e si riferisce all'edizione C.E.
G
ADDA
, Il castello di Udine, in RRI,
pp.
109-281
.
8
Nel testo sarà indicato con L'A e si riferisce all'edizione C.E.
G
ADDA
, L'Adalgisa, in RRI, pp. 283-564.
9
L'edizione a qui si farà riferimento nell'analisi, indicandola con la sigla F220 è C.
E.
G
ADDA
, Un
fulmine sul 220, a cura di D.
I
SELLA
, Milano, Garzanti, 2000.
9
motivata dalla necessità di studiare questo testo, da poco noto: è un elemento nuovo
nella ricerca gaddiana e mi è parso importante includerlo.
10
Non sarebbe necessario giustificare la scelta di esplorare il modo in cui Gadda si
relaziona nei confronti della tradizione classica; la stilistica delle fonti è una prassi nota
e lo studio delle fonti mitologiche e bibliche (o liturgiche) per un autore italiano del
Novecento è un "classico" della scrittura critica. Essendo questo campo ancora
inesplorato per il nostro autore e combinandosi la matera con i miei interessi è nata la
decisione di occupami proprio di questo aspetto.
Per la cultura classica si conosce la biblioteca di Gadda,
11
le sue letture, i suoi
interessi, ma per il resto sembra che non sia ancora stato evidenziato che la mitologia
compare nell'opera gaddiana non solo nel titolo Eros e Priapo o nei nomi di alcuni
personaggi del Pasticciaccio, come Enea e Diomede.
12
Solo lo studio di Rinaldi
13
verte
in modo specifico sul problema della mitologia.
Sul rapporto con la religione si trovano degli indizi, di tipo biografico, nelle
pagine di Il duca di Sant'Aquila di Roscioni; ma a livello di analisi dei testi, dei suoi
"tributi" alla cultura cristiana, vi è un vacuum. È noto che Gadda proviene da un
ambiente cattolico; egli stesso lo riconosce in un'intervista di Dacia Maraini
14
ma
afferma che né il padre né la madre erano «eccessivamente osservanti» ma «avevano il
rispetto per le forme».
15
E di sé stesso dice: «certo l'educazione cattolica ha influito
molto su di me. Perché io prendevo sul serio l'idea del peccato, i rimorsi, le
confessioni».
16
Gadda afferma di aver partecipato sentimentalmente alla religione fino
alla pubertà
17
e di essersene liberato grazie ad un professore che gli aveva parlato della
10
L'indice fornito per gli elementi religiosi e quello per gli elementi mitologici sono i primi per il F220,
dato che al momento della stesura degli Indici, l'opera non era ancora nota. Cfr. appendice 12.1 e 12.2.
11
Vedi ad esempio P.
I
TALIA
, Glossario di Carlo Emilio Gadda ´milanese´. Da "La meccanica" a
"L'Adalgisa, Alessandria, Edizioni dell'Orso, 1998.
12
Su queste figure vedi le osservazioni di Bertoni in F.
B
ERTONI
, Il modello della pittura, in Id., La verità
sospetta. Gadda e l'invenzione della realtà, Torino, Einaudi, 2001, pp. 223-26.
13
R.
R
INALDI
,
I dioscuri senza Leda, cit., pp. 53-57.
14
C. E.
G
ADDA
, Carlo Emilio Gadda come uomo, in Id., "Per favore, mi lasci nell'ombra". Interviste
1950-1972, a cura di C. V
ELA
, Milano, Adelphi, 1993, pp. 154-74 (a p. 155). Il volume sarà indicato con
Interviste.
15
Ivi., p. 160.
16
Ibid.
17
Dice la sorella Clara in un'intervista: «era [Gadda] religioso perché era la tradizione di famiglia, e
quindi ricordo che andavamo tutti a messa col papà, la mamma, noi tre ragazzi nella chiesa di San
Simpliciano», da C. E.
G
ADDA
, Carlo Emilio Gadda, in Interviste, pp. 207-32 (a p. 225).
10
teoria dell'evoluzione. Sarebbe interessante uno studio approfondito sul rapporto che
Gadda intratteneva con la religione, prendendo in considerazione anche le sue lettere;
ma concentriamoci dapprima sulla presenza nei primi romanzi degli elementi religiosi e
mitologici, cominciando da questi ultimi.
11
3.
P
RESENTAZIONE DEGLI ELEMENTI MITOLOGICI
18
Ho scelto lo stesso metodo per esaminare tanto gli elementi mitologici quanto
quelli religiosi (capitolo 4). Dapprima la fase della schedatura, di cui presento un sunto
nel capitolo 3.1 (e 4.1) e di cui fornisco i risultati sotto forma di tabella, riportata in
appendice (capitolo 11.1. e rispettivamente 11.2). Segue l'analisi della microstruttura, in
cui si presentano le funzioni stilistiche degli elementi considerati, per comprendere in
quale modo Gadda usi la mitologia (e la religione). Si passa poi alla macrostruttura: le
forme narrative di ispirazione classica (e religiosa) sono portate alla luce per verificare
se Gadda proceda allo stesso modo, nei confronti della tradizione, a livello
dell'organizzazione del testo,. A questo punto verranno presentate le prime conclusioni.
Provvisorie perché nella seconda sezione si procederà alla loro riprova tramite degli
esempi scelti, e solo a quel punto, tramite anche il paragone degli esiti della ricerca per
l'ambito mitologico e religioso, sarà possibile giungere a delle conclusioni definitive.
3.1
S
CHEDE PER GLI
I
NDICI
Nel corpus da me studiato, sono stati schedati circa centocinquanta elementi
mitologici, tra cui figurano riferimenti alla mitologia greca, romana, babilonese, egizia e
nordica. Prevale la mitologica greca, segue la romana (anch'essa presente in modo
cospicuo), poi la babilonese, l'egizia e la nordica. Si tratta per la grande maggioranza di
nomi di divinità o eroi, e vi sono alcuni riferimenti a luoghi e fiumi dell'oltretomba.
Molti di questi termini erano incompleti (talora mancanti) negli Indici e si spera di
offrire qui una sistemazione per quanto concerne gli elementi considerati. Alla fine di
questa ricerca è stata allegata una tabella
19
in cui compaiono i termini in ordine
alfabetico, le indicazioni presenti negli Indici riferiti alle tre opere, e i riferimenti
riscontrati. Va considerato che per Un fulmine sul 220 si tratta del primo indice
disponibile. A differenza degli Indici, sono state separate le schede del mondo romano
da quello greco (un'indicazione per la voce "Venere" e una per la voce "Afrodite"). Gli
Indici contengono solo i nomi propri, di persona o luogo; nella mia tabella figurano
18
Per la stesura di questo capitolo faccio riferimento alle mie schede, condensate in una tabella, riportata
in appendice 12.1 Elementi mitologici.
19
Vedi appendice 12.1 Elementi mitologici.
12
anche nomi comuni, come "mito" o "gigante". All'inizio dell'appendice 12.1 è stata
posta una tabella relativa al campo semantico di "mito"; segue la tabella con le schede
dei vari elementi mitologici, e infine vi è una tabella relativa al campo semantico di
"musa". Sulla destra compaiono le indicazioni presenti negli Indici per fornire al lettore
un confronto diretto che permetta di valutare quali siano le voci schedate per la prima
volta o completate solo ora.
I termini ricorrenti sono: mito (sei schede), Sardanapalo (sei), Apollo (cinque),
Giove (cinque), Saturno (cinque), Venere (cinque), Erebo (quattro), Sisifo (quattro) e
società musogonica (quattro). Il numero delle schede non deve però trarre in inganno:
Sardanapalo figura sì sei volte, ma cinque nello stesso capitolo (in Teatro, MdF, è il
nome di un personaggio della pièce), dunque non si può affermare che sia un nome
mitologico particolarmente presente a Gadda. Il numero di ricorrenze non basta dunque
a determinare quale personaggio (o episodio) sia una forte fonte di ispirazione gaddiana.
Solo per "mito" e per "musa" si può parlare di una certa importanza perché sono
presenti anche nei loro derivati in modo significativo (ho per questo deciso di
occuparmi della "società musogonica" come elemento esemplificativo nella seconda
parte
20
).
"Mito" e le parole del suo campo semantico figurano nelle opere considerate sei
volte al singolare
21
e una volta al plurale. Il termine "mitologia" è un hapax, mentre
l'aggettivo "mitologico" ricorre due volte al maschile singolare, una volta al femminile
singolare e una al plurale. È interessante esaminare in quale contesto compaia il termine
"mito" per individuare quale valore abbia per Gadda. Lo usa dapprima in riferimento
alla guerra:
Il parlare della guerra e della pace come di un mito, o come del terremoto, è cosa ripugnante in un
uomo e in un cittadino [...] La guerra si deve volere o non volere da uomini: il parlare della guerra
e del governo come di un mito non è cosa degna da uomini (CdU, p. 129).
Il fascismo fece della prima guerra mondiale il suo mito per eccellenza, uno di quelli
che non poteva essere attaccato o scalfito, e in questa citazione sembra che Gadda
commenti questa ideologia e vi si opponga
22
. La guerra, secondo lui, non deve essere un
20
Vedi capitolo 5 Società musogonica.
21
Mito: CdU 129, 130, 132; L'A 314, 385, 401; miti: CdU 186; mitologia: F220 129; mitologico: F220
128; L'A 484; mitologica: L'A 136; mitologiche: MdF 23.
22
Vedi capitolo 8 I soldati: santi e martiri.
13
mito ma è e deve rimanere una realtà. Ancora nel capitolo Elogio di alcuni valentuomini
usa "mito" parlando del Principe: «Leggendo certe pagine del Principe non si riesce
quasi a capire se sono verità o ferocia o spasimante ironia. Forse i tre termini sono uno
solo, fuori dal minestrone dei miti. Navigare nella minestra, ma cercare di capire come è
fatta» (CdU, p. 130). Il termine compare dunque ancora in riferimento (anche se in
modo meno diretto) alla guerra. Stesso contesto per la terza citazione: «Il mito della
furberia è un ignobile e turpe mito» (CdU, p. 132). La quarta volta in cui Gadda usa
"mito", lo riferisce non alla guerra ma all'immaginario della gente:
E allora l'avvocato Cazzuola si fece coraggio, e spifferò fuori tutto: e contò su, tutto: e anche la
storia della lotteria, col viaggio in Palestina per il prete vincitore della lotteria. Ché non soltanto i
Filiberti e Romolo e Remo erano stati tirati in ballo dalla beffarda inventiva del bancarottiere,
nonché inventore della corazza parapalle ed eporapsodo: Romolo e Remo, ben s'intende, con
contorno di Amerigo Vespucci, di lupa, di aquile: e il leone di San Marco [...] e altri volatili e
quadrupedi e sassi e pirocorvette del mito e della storia; ma neppure Goffredo di Buglione e il
Santo Sepolcro furono lasciati in pace (L'A, p. 314; il corsivo è mio).
Sono proprio le figure mitiche evocate dai truffatori che fanno cadere in inganno la
gente (preti
23
e milanesi). Nella quinta e nella sesta citazione "mito" ha ancora il
medesimo significato, indica cioè l'insieme delle immagini leggendarie di un popolo. Se
nella quarta citazione si riferiva al popolo italiano, nelle prossime due si tratta del mito
del Serruchon (L'A, p. 385 e 401). In entrambi i casi "mito" è inserito in un contesto
ironico: «Parallelamente a ciò, nel mito e nel folklore del Serruchon si fece strada l'idea
che il pianoforte sia strumento pericolosissimo, da carrucolar fuori in giardino senza
perdere un istante, non appena si vede venire un temporale» (L'A, p. 385) e «Nel mito e
non folklore locale [...] si seguitò a credere e a sostenere, a Lukones, fosse stata la
spada del pesce-spada a perforare la parete del duodeno» (L'A, p. 401). Possiamo
concludere dunque che Gadda inserisca "mito" riferito alla guerra (primi tre casi) e in
un contesto ironico (ultimi tre casi). Sono miti contemporanei e non greci o latini a cui
si riferisce. È importante notare come "mito" sia usato non in riferimento a opere
letterarie, a fonti, ma abbia un valore politico e sociale. È un mito concreto di cui parla
Gadda, come afferma lui stesso in un' intervista al microfono del 1950:
Capii che dovevo stringere entro più severi limiti la descrizione e l'invettiva, e far posto nelle mie
note alla immatricolazione dei "tipi" umani, dei "personaggi", umani o mitici o bestiali, e delle loro
impagabili vicende.
24
23
Torneremo su questo episodio nel capitolo 7 La figura del prete.
24
C.E.
G
ADDA
, Intervista al microfono, in Id., I viaggi e la morte, Milano, Aldo Garzanti, 1958, pp, 93-
96 (a p. 94).
14
Assumiamo come ipotesi di lavoro questa affermazione: che la descrizione tramite il
mito sia un modo per parlare della realtà.
Torniamo ora alle schede. Esse contengono altri elementi che non figurano nella
tabella allegata, ma che spiego brevemente per illustrare il modo in cui ho operato. Ho
innanzitutto riportato per intero la citazione che contiene l'elemento mitologico. Per
poter organizzare il materiale raccolto ho indicato accanto ad ogni lemma la funzione
stilistica, la parola chiave della citazione, e a che cosa si riferisse. Ho potuto così
individuare un leitmotiv, la società musogonica (che sarà analizzata nel capitolo 5), e le
funzioni stilistiche principali, che esamineremo nel prossimo capitolo.
Come detto nell'introduzione, una difficoltà con cui si scontra questa ricerca è la
mancanza di letteratura critica sull'argomento. Mi sembra però importante segnalare
due saggi. Il primo è l'intervista intitolata Emilio e Narciso
25
dove Gadda propone il
mito di Narciso e ne commenta le varie fonti; mostra proprio come Gadda stesso
proceda nei confronti della mitologia. Il secondo è il saggio di Rinaldi intitolato I
dioscuri senza Leda;
26
è un'analisi del mito dei Dioscuri nell'opera giovanile di Gadda,
volta a dimostrare l'importanza dell'influsso di D'Annunzio; il mondo mitologico è
presentato attraverso il filtro di un altro autore. Questo studio è dunque tematicamente
affine ma l'approccio diverso non offre molti spunti per questa ricerca.
3.2
F
UNZIONE STILISTICA DEGLI ELEMENTI MITOLOGICI
Sono state riconosciute sei funzioni stilistiche: ekphrasis (3.2.1), metafora
(3.2.2), paragone (3.2.3), elenco (3.2.4), epigrafe e citazione (3.2.5). Ordinando gli
elementi secondo queste categorie, rimarrebbero esclusi solo quelli del capitolo Teatro,
in MdF, che si riferiscono ai personaggi teatrali (una ventina), come Sardanapalo o
Agamennone, che non verranno però considerati in questa analisi. Le principali funzioni
stilistiche sono l'ekphrasis (una ventina gli elementi schedati), la metafora (una
cinquantina) e il paragone (una quindicina); l'elenco ricorre poche volte (cinque),
mentre epigrafe e citazione sono un hapax.
27
25
C.E.
G
ADDA
, Emilio e Narciso, in Id., I viaggi e la morte, cit., pp. 215-33 (a pp. 223-33).
26
R.
R
INALDI
,
I dioscuri senza Leda, cit.
27
Se aggiungiamo le dodici schede del campo semantico di mito e le quattordici della società
musogonica, si arriva al totale approssimativo di centocinquanta schede.
15
Procediamo dunque all'analisi della microstruttura per vedere come Gadda
proceda nei confronti della tradizione, e vediamo se l'ipotesi precedentemente avanzata,
secondo la quale Gadda non sia direttamente interessato al mito ma che si serva degli
elementi mitologici per parlare d'altro, è verificata.
3.2.1 Ekphrasis
L'ekphrasis è la descrizione non di paesaggi o situazioni ma di oggetti
concreti.
28
Nel corpus considerato vi sono 20 riferimenti mitologici usati per la
descrizione. Si tratta in particolare di statue e dipinti, visti nei vari musei, di cui Gadda
narra nella seconda parte del CdU, Crociera mediterranea. Vi sono anche alcune
descrizioni di fontane, come quella in La festa dell'uva a Marino, in CdU, e ricorre la
statua funeraria di Saturno, che viene meticolosamente ripulita dall'Adalgisa in F220 e
in L'A. Sarebbe estremamente interessante studiare come Gadda procede nei confronti
delle opere artistiche (ma uno studio monografico sarebbe opportuno): quando la
mitologia diventa vivente, nel senso di tangibile o comunque reale, colpisce in modo
forte l'immaginario gaddiano, tanto che l'autore si serve delle statue e delle fontane
viste per creare metafore e paragoni. Le visite ai musei non sono semplicemente
annotate e poi dimenticate, ma sedimentano nella mente di Gadda. Emerge nell'ekprasis
l'amore per il mondo classico e per l'arte greca e romana, che sembra essere una sua
fissazione: «D'altronde quella del Museo Nazionale è una vecchia mania, da cui, lo
sento, non guarirò più»(CdU, p. 188).
Il modo in cui Gadda descrive fa sorridere il lettore: il sorriso nasce a volte dalla
brevità delle descrizioni (che risultano quasi un'enumerazione), oppure
dall'aggettivazione scelta per connotare le varie statue, talvolta dalla poeticità con cui
egli si esprime (l'innescamento di un registro più alto comporta un effetto comico), o
ancora dai commenti che aggiunge en passant (vedi numerosi esempi in CdU, p. 188).
Gadda descrive e allo stesso tempo si nega la possibilità di fare delle descrizioni;
afferma infatti «celebrare il molle splendore di lei [l'Anadiomene Rodia] [...] non è
compito che spetti alla nostra scrittura» (CdU, p. 205). Su quale sia il suo vero scopo si
28
Per vedere i diversi tipi di descrizione vedi in H.
L
AUSBERG
, Elemente der literarischen
Rhetorik, Ismaning, Max Hueber, 1990, la voce "ekphrasis".
16
tornerà più volte in questa analisi. Importa ritenere che Gadda non vuole che la
mitologia diventi una fonte solo per le descrizioni.
3.2.2 Metafora
Circa una cinquantina di metafore sono costituite da elementi mitologici (così
dalle mie schede); è questa la funzione stilistica predominante. Gadda si serve dunque
della mitologia per non parlare direttamente di qualche cosa; o potremmo anche dire
per parlare indirettamente di qualche cosa. La mitologia è come una maschera che viene
calata su un argomento. Ma volte è tanto deformante che non si riesce a riconoscere il
volto di chi la porta (e dunque il tema non emerge mai in modo chiaro); altre volte le
fessure degli occhi sono tali da permetterci di riconoscere la persona che indossa la
maschera. La maschera, proprio come la metafora, permette di assumere atteggiamenti,
di dire certe opinioni, senza venir riconosciuti e dunque senza correre rischi. La
metafora permette a Gadda non solo di esprimersi su un certo tema (come ad esempio il
comportamento degli ufficiali in guerra) senza esporsi, ma è la chiave d'accesso per
affrontare un determinato tema, che senza la metafora, apparirebbe in modo diretto e
comporterebbe dei problemi (con il regime fascista o più semplicemente con le
aspettative del pubblico). Soltanto la metafora mitologica rende certi argomenti dicibili.
La metafora ricorrente è quella che descrive la società milanese come "società
musogonica" (vedi capitolo 5).
Sovente l'uso in metafora della mitologia serve a creare un effetto parodico. È il
caso di quando Gadda parla dei soldati che ritornano molti anni dopo la guerra dalla
Russia. Il loro rientro fa perdere la pensione alla moglie, che nel frattempo si credeva
vedova, e che, insinua Gadda, «aveva preso a filare e a tessere, alla facciazza di
Penelope»
29
( MdF, p. 78). Questa metafora allude al fatto che la moglie stava forse
cedendo a nuovi amori, proprio il contrario di Penelope, che invece disfaceva quanto
aveva tessuto per non sposare i pretendenti. Oppure i personaggi sono definiti in modo
metaforico e parodico, come i lavoratori della Confidenza, i lucidatori dei parquets
29
Cfr. il commento di Rinaldi sulla figura del "reduce ulissiaco", in R.
R
INALDI
,
I dioscuri senza Leda,
cit., pp. 55-57.
17
milanesi, che sono detti «alunni [...] di Hermes carrucolatore»
30
(L'A, pp. 105-06); o i
giornalisti che scrivono sul "Corriere della Sera" presentati da Gadda come «i
minotauri» (F220, p. 36).
In generale si può affermare che la mitologia nelle metafore è usata in due modi.
Mi permetto di definire topico il primo: è il caso dell'utilizzo di Morfeo per indicare il
sonno, o di Penelope come moglie che attende il ritorno del marito (come visto sopra
nell'esempio da MdF, p. 78), o quando chiama l'Etna «solitario gigante» (CdU, p. 189);
è una metafora abbastanza scontata che rientra quasi nei modi di dire. Il secondo uso
crea invece stupore: ad esempio quando parla della tavola da lavoro al Politecnico,
definendola «la mia rubinettifera e milanese Penelope»
31
(CdU, p. 151), oppure la
presentazione del macellaio Fumagalli (L'A, p. 113-14) come «Oromedonte in camice»
(riferendosi cioè al titano Giapeto) o come «Briareo prosciolto»; la metafora è ricercata
e inusuale: non solo per l'accostamento di significato e di stile, ma anche per
l'aggettivazione della figura mitologica. La novità consiste proprio nell'accostamento di
un termine aulico a uno basso.
32
Non si può parlare di un uso univoco della metafora, poiché un elemento
mitologico in metafora non indica sempre lo stesso personaggio o la stessa situazione.
33
Questo procedimento va forse letto alla luce di quanto Gadda afferma in un'intervista
del 1950: «le figure, talora, diventano simboli: e io aborro dal personaggio-simbolo,
come aborro dal personaggio-araldo»
34
. Se Gadda avesse sempre indicato un
personaggio con lo stesso elemento mitologico si sarebbe appunto creata una figura-
simbolo.
30
Roscioni afferma: «L'estro goliardico di Gadda si sbizzarrirà, per esempio, ad affibbiare buffi attributi
ed epiteti agli dei del mondo pagano ([...], "Minerva Chilifera", "Hermes Carrucolatore" [...])», in G.
C.
R
OSCIONI
, La disarmonia prestabilita. Studio su Gadda, Torino, Giulio Einaudi, 1969, p. 122.
31
Citando proprio questo passaggio Silvestri scrive: «con vertiginosa moltiplicazione dei piani, Gadda
realizza qui nella sua scrittura un'"esplosione" (come si dice in termine tecnico) in diverse prospettive del
pezzo meccanico disegnato e ridisegnato pazientemente (e la pazienza estrema è esplicitata dalla metafora
della tela di Penelope)», A.
S
ILVESTRI
, Gadda studente di Politecnico e ingegnere,in Per Gadda il
Politecnico di Milano. Atti del Convegno e Catalogo della mostra. Milano 12 novembre 1993, a cura di
A.
S
ILVESTRI
, Milano, Scheiwiller, 1994, pp. 41-58 (a p. 43).
32
G.
C.
F
ERRETTI
, Ritratto di Gadda, cit., pp. 76-77.
33
A volte un personaggio è definito sempre con la stessa metafora, ad esempio Ugo Betti nel CdU è
sempre indicato con "Apollo", oppure il sonno che è sempre personificato da Morfeo; ma "Apollo" non
indica sempre Betti, né "Morfeo" sempre il sonno.
34
C.E.
G
ADDA
, Un'opinione sul neorealismo, in Id., I viaggi e la morte, cit., pp. 211-13 (a p. 211).
18
Sarebbe interessante studiare sistematicamente la metafora nell'opera gaddiana,
perché non sono solo metafore usuali o topiche che l'autore impiega. Esse rivelano una
buona conoscenza della mitologia, in particolare greca e romana.
35
Gadda non utilizza
però miti, ma solo personaggi mitologici, e non è quindi possibile determinare a quali
letture si ispiri e quali lo abbiano particolarmente influenzato. Tramite gli elementi
schedati non è possibile ricostruire le fonti letterarie.
3.2.3 Paragone
Una quindicina di volte Gadda ricorre nei quattro romanzi esaminati agli
elementi mitologici per costruire un paragone. Quanto affermato per la metafora vale
anche per questa figura: vi è un doppio uso, topico e innovativo. La maggior parte dei
paragoni sono piuttosto usuali, come i diavoli in scena paragonati ai fauni (MdF, p. 15),
gli uomini che il giorno del Giudizio vorranno incantare con le loro parole come
Alcibiade (CdU, p. 120), la cima tra le nebbie dei monti come la testa di Giove tra le
nuvole (CdU, p.148), le perle della collana dell'Adalgisa come albicocche dell'Ade
36
(F220, p. 175 e L'A, p. 548), l'avvocato Cazzuola che gonfia le gote come Atena
flautante (L'A 312), il cane che latra come Agamennone (L'A, p. 328), Elsa bella come
un'immagine musiva (L'A, p. 499). Il secondo uso è dato dai paragoni meno topici, che
come le metafore non colpiscono per la ricercatezza del termine di paragone, quanto
piuttosto per l'accostamento degli elementi paragonati; ad esempio la signora Vigoni
prende posto nella disperazione dell'Adalgisa come i penati nella nicchia (F220, p.
173), Zavattari guarda Bruno come un oracolo (F220, p. 181), l'istinto materno è come
la voce dei profeti e delle sibille (L'A, p. 371), il cibo in eccesso nuoce allo stomaco
come i Danai entro Troia (L'A, p. 397), Bruno dopo l'incidente coi cioccolatini sembra
un'ombra pentita di aver attraversato lo Stige (L'A, p. 444). Anche la connotazione
delle figure mitologiche è interessante: Giove è «coglione» (CdU, p. 148), Atena è
«flautate» (L'A, p. 312). Compare di nuovo un effetto parodico. A poco a poco la
35
Scrive Pecoraro: «Le coincidenze fra l'elenco dei classici e quello degli autori studiati anche a scuola
non indicano una cultura scolastica in senso riduttivo; se di cultura liceale si tratta, lo è nel senso più alto:
ci sono potenzialmente infiniti modi di leggere e assimilare autori come Dante o Shakespeare» (A.
P
ECORARO
, Gadda, cit., p. 36).
36
Questo paragone meriterebbe di essere studiato con più attenzione; cfr. anche
F.
B
ERTONI
, Gioielli, in
Id., La verità sospetta, cit., pp. 151-65.
19
parodia si delinea come fil rouge di questa analisi: è questo l'intento che Gadda vuole
raggiungere utilizzando la mitologia.
3.2.4 Elenco
Poche volte (cinque le mie schede) i nomi di dei o eroi mitologici compaiono in
un elenco.
37
Gadda all'inizio della Crociera mediterranea dice: «Voglio Eschilo, voglio
Nausicaa, voglio le Sirti, voglio Scilla, voglio Cariddi...» (CdU, p. 182); li vuole per
cominciare la sua avventura mediterranea, come se il viaggio dovesse essere
accompagnato da queste presenze mitologiche. Un altro elenco è presenta nella
discussione dei passeggeri sul treno (CdU, p. 268): si odono i nomi di Achille e
Menelao tra varie parole non articolate tra loro a formare un discorso compiuto (si ha
piuttosto l'impressione che ci siano riferite delle parole pescate qua e là dalla
discussione).
38
Quando la Confidenza arriva per la lucidatura dei parquets a casa
Cavenaghi, i suoi operai devono spostare una quantità enorme di oggetti «della
prudenza e della demenza domestica» (L'A, p. 301), tra questi vi sono anche
«bomboniere, Lari, leonesse, orologi a pendolo» (L'A, p. 301). Anche qui
l'enumerazione sembra stravagante o disarmonica (e poco sensata). Un altro breve
elenco descrive le incombenze dei domestici della famiglia Cavenaghi, chiamati «a
spolverare la santità un po' malinconica dei Lari,
39
a mutar l'acqua al canarino» (L'A, p.
318).
Quando Gadda propone queste enumerazioni sembra non avere molta
dimestichezza con gli elementi mitologici, ma usarli perché arricchiscono il discorso.
Abbiamo visto invece che Gadda conosce la mitologia. Che la usi forse nello stesso
modo in cui è impiegata nella conversazione borghese?
40
Dei termini che non si
padroneggiano, ma che inseriti in modo sporadico innalzano e nobilitano il discorso, e
danno un'impressione di cultura a chi li ascolta. Questa idea è nata dalla lettura del
37
Più in generale sull'enumerazione cfr. G.
C.
R
OSCIONI
, Singola enumerare, in Id,, La disarmonia
prestabilita, cit., pp. 24-55 (in particolare pp. 24-26).
38
Vi è un elenco nella parte intitolata Dossier del F220, a p. 260, che essendo escluso dal corpus non
verrà trattato.
39
Questa presenza dei Lari nella descrizione della sfera domestica ritorna anche nella Cognizione del
dolore e nel Pasticciaccio (cfr. G.
C.
R
OSCIONI
, La disarmonia prestabilita, cit., pp. 129 e 138-39).
40
Occorre qui fare un'importante precisazione. In quest'analisi si parlerà più volte di "borghesi" e
occorre intendere i "nuovi ricchi", la cui cultura non è più che una patina fatta di luoghi comuni.
Normalmente si tratta dei borghesi di Milano.
20
capitolo Dal golfo all'Etna, quando descrivendo la crociera Gadda riporta le parole
della guida turistica:
"Qui la première dei Persiani, nel 480, a celebrare la battaglia d'Imera!...", urlava nel teatro il
solerte psicopompo.
"Qui Eschilo...": tutti si voltavano per Eschilo; ma poi chi di qui, chi di là. La mandra non era
facile da contenere e da catechizzare (CdU, p. 189).
Chi partecipa alla crociera sono i borghesi, coloro che si interessano della cultura
musiva (vedi capitolo 5). Pare impossibile che non sappiano chi sia Eschilo eppure
Gadda li dipinge in questo modo. L'autore vuole mostrare che i borghesi non conoscono
i termini che usano nella conversazione: non sono certo gli impiegati della Confidenza
né le domestiche brianzole a parlare di «lari». In entrambi i casi, come nel discorso sul
treno, il ricorso a un termine della mitologia crea un effetto parodico. Gadda sembra
farci intendere che dietro ai nomi non vi siano veramente dei riferimenti precisi, una
solida cultura (come vedremo nel capitolo Il credo nel Politecnico) e che quindi i
borghesi
41
usino a sproposito i termini alti. Si delinea dunque un nuovo elemento
centrale per la nostra analisi: i termini mitologici sembrano essere usati per fare della
parodia sulla borghesia.
3.2.5 Epigrafe e citazione
Nelle opere considerate vi è una sola epigrafe, posta all'inizio del capitolo
Manovre di artiglieria di campagna, e in essa è presente l'aggettivo "mitologico": «Tiri
di batteria: da 75 e da 100. Descrizione magnificata da due ipotiposi mitologiche e da
diverse locuzioni dell'uso raro» (MdF, p. 23). Si è cercato nel capitolo a che cosa si
riferissero le due descrizioni mitologiche: una indica certamente il generale
42
definito
sempre tramite la metafora dell'alunno di Marte; l'altra non so se riferirla al «manzo
sardanapalesco» (mi sembra l'ipotesi più attendibile) o al cavallo che ha nome Gorgo.
Che Gadda scelga di esplicitare nell'epigrafe il suo modo di narrare, definendolo
arricchito da descrizioni in chiave mitologica, è un grande suggerimento al lettore, ma è
un segnale ancora più importante per la nostra indagine. Gadda afferma, e lo fa
41
Vedi nota precedente.
42
Cfr.
G.
C.
R
OSCIONI
, Che cosa è un generale, in Id., La disarmonia prestabilita, cit., pp. 94-120.
21
nell'epigrafe,
43
che la presenza di elementi mitologici sono una componente voluta e di
forte significazione, a cui ricorre per dire altro.
Nel corpus considerato compare un'unica citazione latina: «Dum rediens fugat
astra Phoebus» (CdU, p. 236). È l'ultimo verso del carmen 3, 21 di Orazio, dall'incipit
O nata mecum consule Manlio. Questa citazione ha un valore metaforico e di paragone:
come il sole fa partire le stelle, così la festa dell'uva deve far scomparire i pensieri di
morte di Gadda. È significativo che proprio nell'unica citazione come nell'unica
epigrafe compare un elemento mitologico.
3.3
G
ADDA E LA TRADIZIONE CLASSICA
In questo capitolo sono stati presentati gli elementi mitologici, schedati
all'interno delle opere considerate, e sono state brevemente schizzate le loro funzioni
stilistiche. Dalla ricerca risulta una preferenza per la mitologia classica (più greca che
romana) che sembra essere usata prevalentemente in modo metaforico e come paragone.
Un primo importante risultato è che la mitologia è una componente significativa
per Gadda, (come egli stesso segnala nell'unica epigrafe) a cui ricorre in modo
ragionato per costruire la narrazione.
Secondo: è stato accertato che Gadda non si interessa al mito ma ai personaggi
mitologici. Per questo motivo è impossibile ricostruire le letture gaddiane, ma appare
evidente la conoscenza di episodi mitologici famosi, di eroi e dei importanti,
sicuramente acquisita tramite la lettura di opere classiche, ma anche attraverso viaggi e
visite a musei.
Terzo: la mitologia non è una fonte letteraria per Gadda. Non è quindi possibile
svolgere un'analisi di macrostruttura, poiché non vi sono modelli narrativi a cui si rifà
in modo evidente. Non si ispira alle letture per scrivere, non narra prendendo spunto da
un episodio mitologico, ma narrando ricorre al mito per dare un'intonazione, un taglio
particolare a ciò che lo interessa.
Quarto: la mitologia è usata come elemento retorico, non tematico,: sovente vi è
l'accostamento aulico-prosastico (l'aggettivazione è grottesca o ironica). Se da una
43
Per l'importanza della sede epigrafica cfr. G.
G
ÉNETTE
, Seuils, Paris, Éditions du Seuil, 1987, pp. 145-
49.
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2004
- ISBN (eBook)
- 9783836629690
- Dateigröße
- 573 KB
- Sprache
- Italienisch
- Institution / Hochschule
- Universität Basel – Philosophisch Historische Fakultät
- Erscheinungsdatum
- 2014 (April)
- Note
- 1,0
- Schlagworte
- carlo emilio gadda mythos religion quellenarbeit fonti
- Produktsicherheit
- Diplom.de